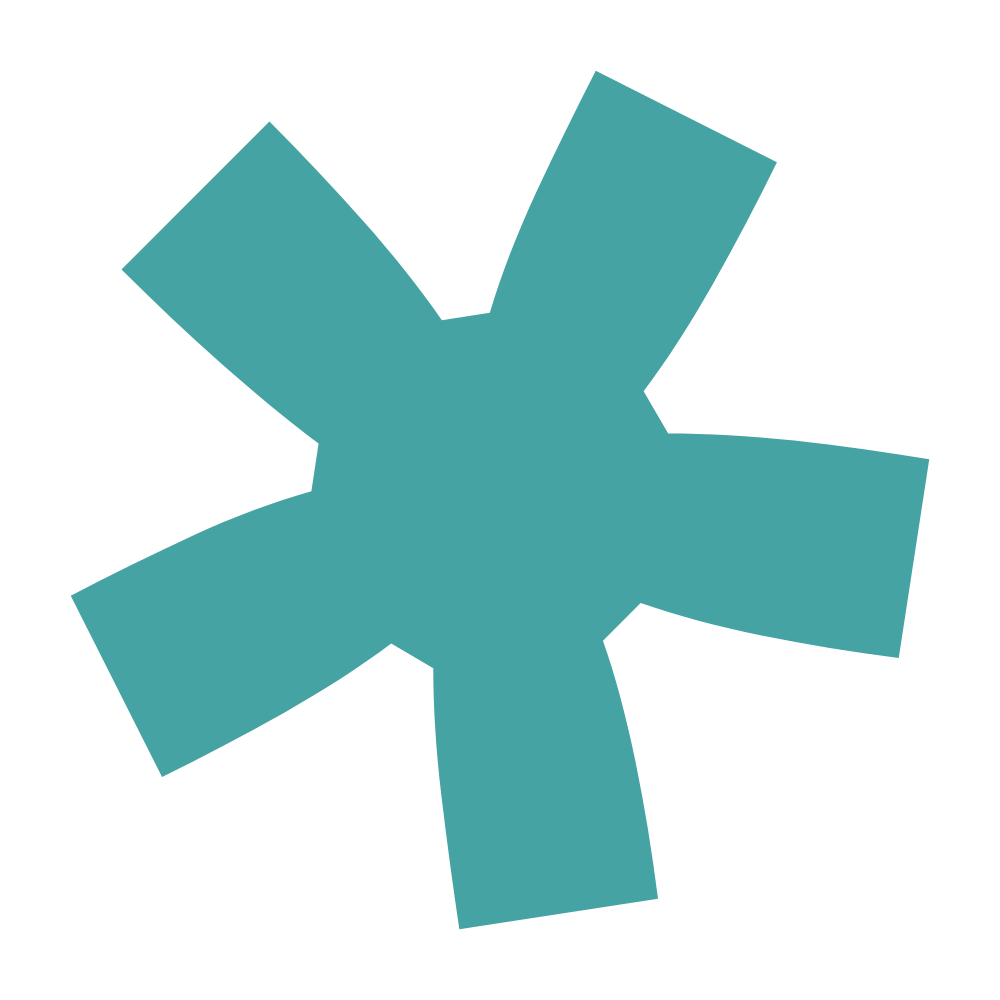Maledetta quella volta che ho deciso che avrei fatto il Consulente
Questo è il racconto di una scelta sbagliata.
Sbagliata su così tanti livelli, che a posteriori la compierei ancora, e ancora. Insomma, se errare è umano, ma perseverare è diabolico, per quel che riguarda questa scelta in particolare mi sento decisamente diabolico.
La scelta in questione è relativa alla carriera che avrei intrapreso. Ma permettimi di fare un salto indietro nel tempo. Immagina: c’è questo ragazzo promettente, più o meno, che è appena uscito da una laurea triennale in economia. Vive ancora a casa, e fa lo studente, ma ha deciso che vuole guadagnare due lire in più. Potrebbe andare a fare il barista, come fanno tutti, e invece no. Decide che vuole fare il consulente per le aziende.
Giovane neolaureato, perché hai preso questa decisione foriera di sventure?
Non è molto bravo, in questo momento della sua carriera, ma in un modo o nell’altro si arrangia. Grazie ad amici di amici riesce anche a trovare qualche cliente. Il suo lavoro lo fa. Viene anche pagato. Insomma, non tutto è rose e fiori: ho detto prima che questo ragazzo non è poi così bravo, e quindi gli capita di sbagliare. Alcuni clienti si arrabbiano. Qualcuno non lo paga nemmeno, ma va bene così: da ogni esperienza negativa quel ragazzo che ancora studia trae qualche lezione. Impara a definire meglio gli obiettivi dei clienti. Impara a essere più realistico nel definire le loro aspettative. Diventa più bravo nel lavoro vero e proprio.

Fino a quando non si laurea, e allora quel passatempo in qualche modo smette di essere un passatempo. La tempistica è un po’ sfortunata: si laurea e si sposa a pochi mesi di distanza, e subito prima dell’estate. Quando torna dal viaggio di nozze i suoi clienti sono tutti spariti. Non è il momento di iniziare nuovi progetti, ne riparliamo a settembre, gli dicono.
Intanto l’estate passa, e i clienti non arrivano. Quello che arriva, però, sono delle opportunità. Tutti conosciamo la figura mitologica del neolaureato con esperienza, e il ragazzo risponde a questa descrizione. Le esperienze che ha sono anche abbastanza interessanti, quindi non ha fatica a organizzare dei colloqui. Tempo un paio di mesi, e un lavoro l’ha trovato.
Ed ecco, questo è il momento in cui scopre la dura realtà: neolaureato con esperienza significa, letteralmente, qualcuno che sa fare le cose, ma che posso sottopagare. E di cui posso liberarmi senza troppi scrupoli, perché tanto di neolaureati disperati in giro ce ne sono a bizzeffe. Il povero ragazzo se ne rende presto conto.
Lui è diligente. Continua a investire in modo importante sulla sua preparazione. Svolge nuovi corsi, che gli danno strumenti in più. Strumenti incredibili, che potrebbero essere usati davvero dalle aziende per fare le cose diversamente, per farle meglio. Si propone di portarli dentro le aziende per cui lavora, ma non sono interessanti per loro. Deve fare solo il suo piccolo. e quindi ha un momento di realizzazione: aiutare davvero le aziende da dentro, per lui, è impossibile. Può farlo solo da fuori. Come lo faceva una volta, quando i titolari realmente lo ascoltavano. Quando prendevano sul serio il lavoro che faceva insieme. Quegli strumenti che ha studiato gli permettono di capire meglio quelle dinamiche, così come molti degli errori che ha commesso.
Quel ragazzo, che non ha nemmeno trent’anni, ha capito una cosa: che non potrà mai accontentarsi. Uno stipendio non sarà mai sufficiente. Le responsabilità non saranno mai abbastanza. Gli orari mai abbastanza flessibili. E allora compie la scelta peggiore: sceglie di diventare un lavoratore autonomo, un consulente.
Perché in fin dei conti una scelta non ce l’ha. Lui è fatto così, e se la deve mettere via. Lui è uno che deve vedere le cose che cambiano, e deve inseguire obiettivi irrealizzabili. Deve assecondare la sua curiosità compulsiva.
Questa è la mia storia, naturalmente, e ti ringrazio per aver scelto di condividerla con me, attraverso questa lettura!