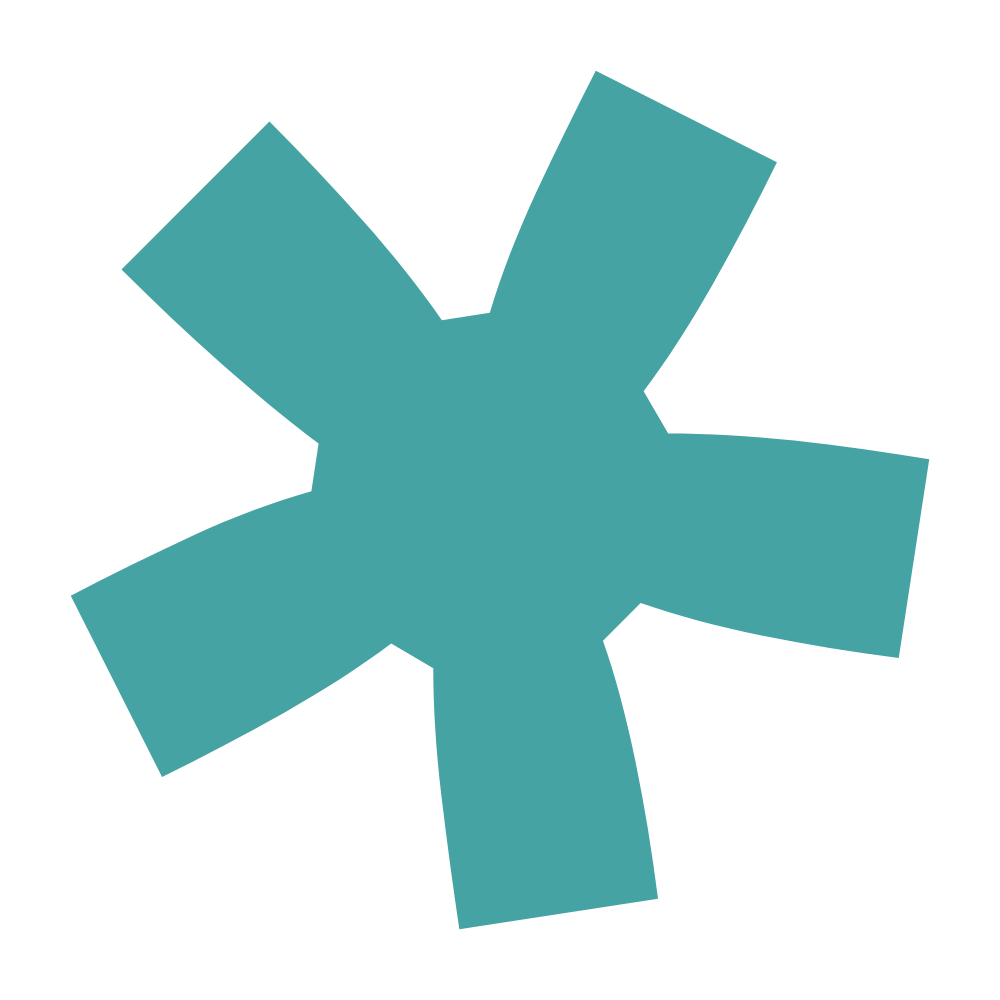Oggi, quando nasce un’azienda, soprattutto se si tratta di una startup dall’alto contenuto innovativo, essa spesso esiste solo grazie allo smart working. Questo perché non ha una sede fisica (costa troppo!) e comunque raccoglie talenti da diverse parti dell’Italia o del mondo.
Ma il fenomeno dello smart working è relativamente recente, abilitato in modo reale da tecnologie che solo fino a una decina d’anni fa erano molto più arretrate e limitanti. Ecco perché le aziende che sono nate prima, e hanno creato un gruppo di lavoro consolidato fanno fatica ad introdurre questo modo nuovo di vedere il lavoro.
Personalmente non sono un apologeta dello smart working a tutto tondo: se, da una parte, ne vedo i benefici evidenti, dall’altra ne riconosco anche i limiti, il principale dei quali è di natura squisitamente comunicativa: le persone hanno bisogno di vicinanza fisica per costruire quelle relazioni solide e forti che fanno da collante all’azienda, e creano la famosa cultura aziendale. Se il contatto è solo virtuale, per quanto possa essere a video e frequente, questo processo di costruzione è molto più lento, e produce risultati non ottimali.
Ecco perché non mi capita praticamente mai di proporre ai miei clienti di adottare soluzioni di smart working: sotto sotto non ci credo troppo. Però di tanto in tanto, è il cliente che avanza la richiesta, e in casi come questo è essenziale costruire una nuova logica lavorativa, senza però distruggere nulla di ciò che è stato creato fino a quel momento.

Il problema
Vengo coinvolto dal giovane HR Business Partner di una realtà relativamente strutturata che conta poco più di 60 collaboratori. In azienda lui è già stato promotore di una serie di iniziative di Welfare Aziendale, e in seguito a un confronto privato mi ha confessato che, nonostante il suo essere propositivo sia apprezzato dalla titolare dell’azienda, nell’ultimo anno ha incontrato delle resistenze particolari proprio per quel che riguarda lo Smart Working, un’iniziativa che, dal suo punto di vista, oltre a migliorare la produttività dell’azienda nel suo complesso, le permetterebbe di espandersi più agevolmente verso l’estero, visto che ad oggi tutta l’attività è focalizzata sulla sede operativa.
Il mio interlocutore sogna di lavoro al 100% da remoto e politiche di ferie illimitate, ed è questo il momento in cui esprimo maggiormente il mio scetticismo. Questi obiettivi, gli spiego, sono spesso irrealistici anche per aziende che nascano intorno a questi ideali, mentre traghettare un’azienda comunque già consolidata ad una situazione come questa sarebbe probabilmente anche controproducente, pure se il modello di business dell’azienda, almeno in teoria, lo consentirebbe, non avendo delle linee produttive interne, né l’esigenza di presidiare costantemente un canale distributivo.
A questo si aggiunge la semplice quanto adamantina opposizione della titolare: “Non siamo pronti“. Obiezione che l’HR Business Partner non è mai stato in grado di gestire.
Prima di prendere quest’incarico, però, avevo l’esigenza di confrontarmi con la titolare dell’azienda, per comprendere la natura della sua resistenza. Vista la descrizione che il mio referente interno me ne aveva fatto, scelsi di farmi presentare come un consulente specializzato in performance aziendale, che desiderava avere il suo punto di vista sugli obiettivi e la strategia aziendale, in modo che il lavoro fatto insieme al suo collega fosse il più efficace possibile.
Il lavoro svolto insieme
Ero consapevole che se volevo aiutare il mio referente dovevo prima, in qualche modo, conquistare il suo capo. La titolare era una persona estremamente volitiva: relativamente giovane, aveva fatto una carriera piuttosto veloce come manager di azienda, e grazie ad alcuni investimenti calcolati era riuscita ad accumulare il capitale che le aveva permesso di acquistare un’azienda prossima al fallimento di un lontano parente, alcuni anni prima, riorganizzarla in modo efficiente e farla tornare in attivo in pochissimo tempo. Negli ultimi otto anni, da quando aveva rilevato la società, aveva avuto l’intuizione di assegnare grande responsabilità a delle persone che si erano rivelate delle scelte vincenti, tra cui anche l’HR Business Partner con cui ero entrato in contatto.
Il primo approccio con la titolare fu meno che tiepido. La presentazione del mio referente era stata un po’ troppo entusiastica, e lei mi osservava con scetticismo. Io le spiegai, quindi, in modo estremamente pacato che ero stato coinvolto dal suo collega per supportarlo su alcuni temi, e desideravo conoscere i suoi obiettivi. Notai che non era particolarmente partecipe mentre mi spiegava di obiettivi di fatturato e crescita di personale, come se stesse semplicemente ripetendo un disco imparato a memoria. A quel punto Mi accorsi degli sguardi che ogni tanto lanciava al mio referente. Decisi di dirgli che per il momento non avevo bisogno del suo aiuto, e non volevo sottrarlo al suo lavoro per più del necessario. Lui colse l’invito implicito e abbandonò la stanza.
Non appena fu uscito, la titolare cambiò immediatamente atteggiamento. Mi disse che sapeva perfettamente quale era il motivo per cui ero stato coinvolto, lo smart working, e non aveva nessuna intenzione di dare il benestare a quel progetto. Ribadì che come azienda non erano pronti. Sorrisi davanti a tanta schiettezza, per la quale la ringraziai, spiegandole che ero d’accordo: non erano pronti.
Lei fu in qualche modo presa in contropiede da quella mia affermazione, e allora rincarai la dose, affermando che il suo collaboratore era davvero troppo entusiasta rispetto a quel tema, ma che condividevo la sua analisi: l’azienda non era pronta. Si erano appena ripresi da un quasi fallimento, e lei non avrebbe dovuto mollare il controllo per un attimo, altrimenti avrebbero rischiato di ricaderci.
Mi resi conto che quell’affermazione l’aveva in qualche modo punta nel vivo, perché rappresentava una verità che lei non voleva ammettere a se stessa: aveva paura che se avesse mollato la presa anche solo per un giorno, l’azienda sarebbe ricaduta nei problemi da cui lei l’aveva faticosamente tirata fuori. Però non voleva ammetterlo, e in qualche modo tentò di minimizzare.
Queste furono le prime battute di una chiacchierata che durò almeno un’altra ora, e fu, di fatto, un’intensa sessione di coaching. Alla fine, però, la menzogna con cui ero stato presentato si era trasformata in verità: parlammo a lungo di obiettivi di performance, di cultura aziendale, e di limiti dei modelli di smart working, e alla fine diede la sua benedizione sull’avviare un progetto pilota con l’HR Business Partner.
A quel punto il vero lavoro poté iniziare. Si decise di partire con una sperimentazione volontaria da parte di non più di dieci persone in uffici vari dell’azienda, per del lavoro da remoto per un giorno la settimana, consapevoli che quello sarebbe stato il primo passo verso l’obiettivo finale concordato con l’HR Business Partner, che era stato rimodulato dal suo sogno un po’ irrealistico. Concordammo, infatti, che la presenza in azienda per almeno due giorni la settimana era essenziale per asserire quel collante di cultura aziendale che poteva essere solo riassunto come “desiderio di rinascere“.. Quei due giorni però sarebbero stati ad orario ridotto (6 ore), mentre per il resto del tempo le persone avrebbero potuto svolgere il lavoro nelle condizioni che preferivano. Si scelse che la politica di ferie illimitate, fortemente voluta dall’HR Business Partner, sarebbe stata valutata in modo concreto solo in una fase più avanzata del progetto.
Oltre alla sperimentazione venne fatto un lavoro di formazione con tutti i manager dell’azienda, titolare compresa, in modo da introdurre e consolidare un modello di delega per obiettivi, anziché per mansioni o compiti, funzionale all’efficacia di un buon progetto di smart working. Venne quindi delineata la mappa di un cambiamento organizzativo che avrebbe coinvolto l’azienda per il successivo anno e mezzo, e che dopo i primi otto mesi sarebbe stato portato avanti solo dal loro HR Business Partner, evidenziando anche tutti gli investimenti formativi, burocratici e di infrastruttura informatica che sarebbero stati necessari.
I risultati
Il benestare della titolare spianò di fatto la strada dell’intervento, rendendolo di successo fin da subito. La sperimentazione iniziale incontrò una risposta entusiasta da parte dei collaboratori, tanto che circa l’80% si dichiararono disponibili a metterla in pratica da subito. Questo portò a gestire la prima fase come un premo per alcuni collaboratori che negli ultimi anni si erano distinti per competenze. Dopo i primi tre mesi la sperimentazione venne estesa progressivamente a tutti i collaboratori che l’avevano richiesta. Attraverso delle sessioni di coaching gestite direttamente dall’HR Business Partner vennero coinvolti anche gli scettici, il restante 20% dei collaboratori.
Nei successivi sei mesi il numero di giorni a casa alla settimana è stato aumentato a due, senza particolari traumi anche grazie al cambiamento di stile di leadership di tutti i manager coinvolti. Quasi alla fine di questo passaggio io ho cessato i miei rapporti con l’azienda, che però mi mantiene aggiornato sui risultati. Ad oggi essa si trova nel terzo step, in cui è stato introdotto il terzo giorno di lavoro da remoto, ed è partita la sperimentazione sulla politica di ferie limitate.
L’azienda nel suo complesso oggi è formata da persone estremamente proattive, che tengono al proprio risultato e non hanno paura ad assumersi le proprie responsabilità. Il turnover in seguito a questo cambiamento si è ridotto, e la performance aziendale è migliorata notevolmente. I due giorni stabili in azienda, il martedì e il mercoledì, vengono utilizzati principalmente per organizzare riunioni su temi strategici (per cui la presenza fisica è importanti), ma in molti casi anche per attività formative e ricreative.
Anche senza considerare gli effetti positivi sul benessere dei collaboratori, questo cambiamento così importante ha già prodotto effetti economici, in termini di miglioramento delle performance aziendale, tali da ripagare abbondantemente gli investimenti sostenuti.