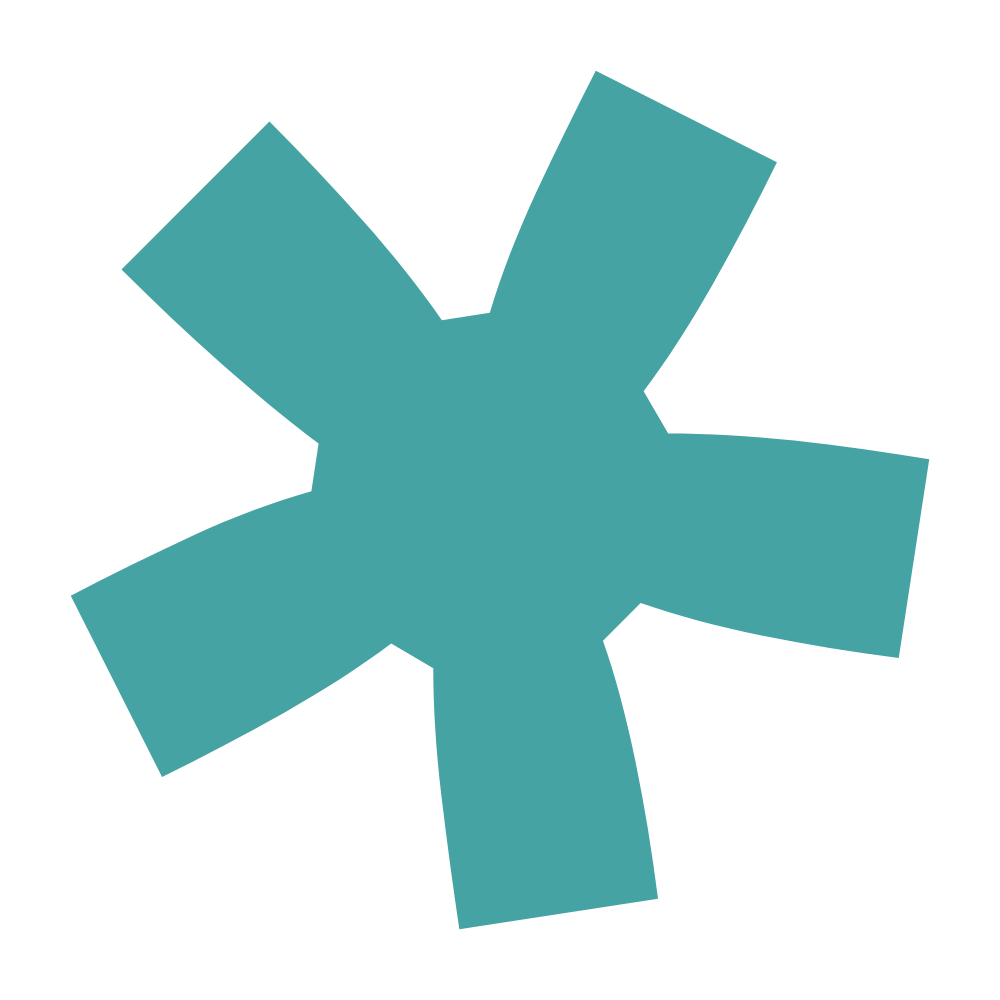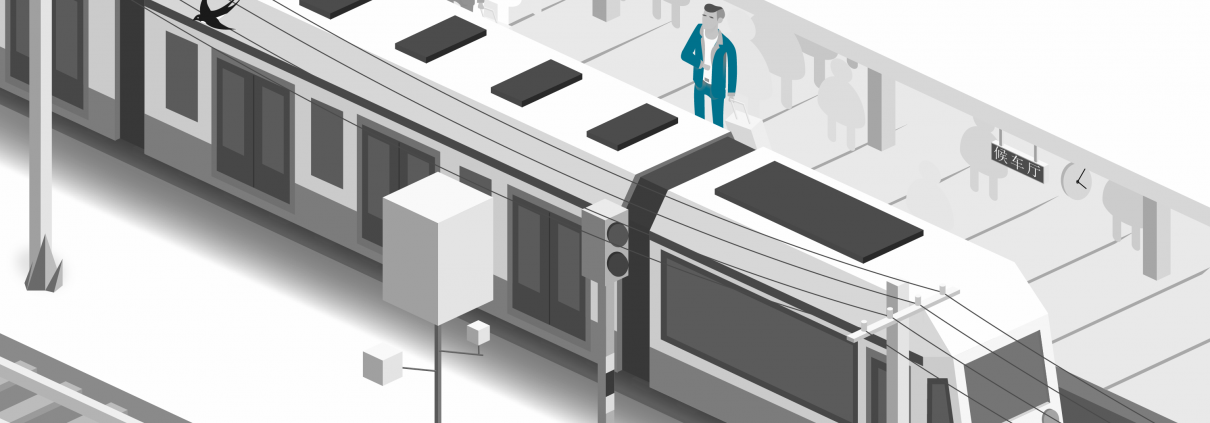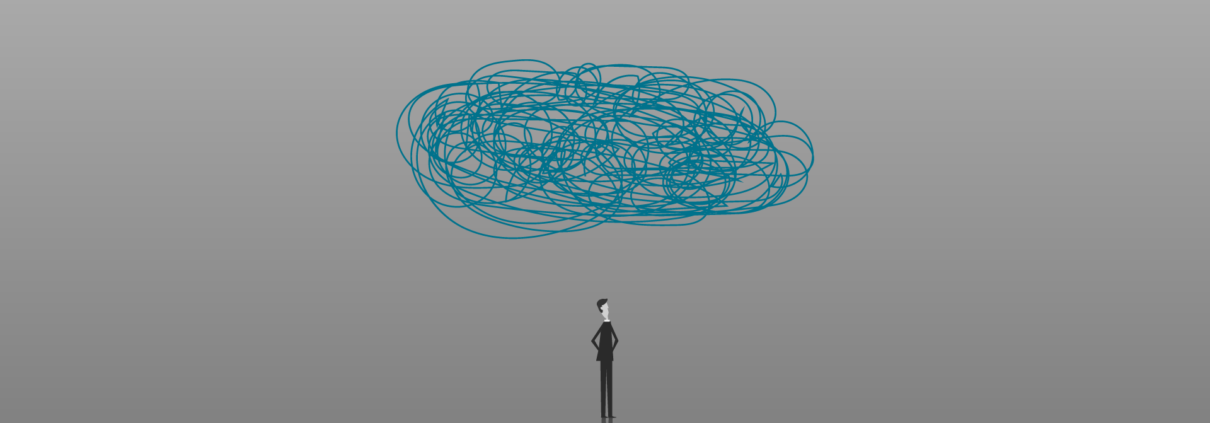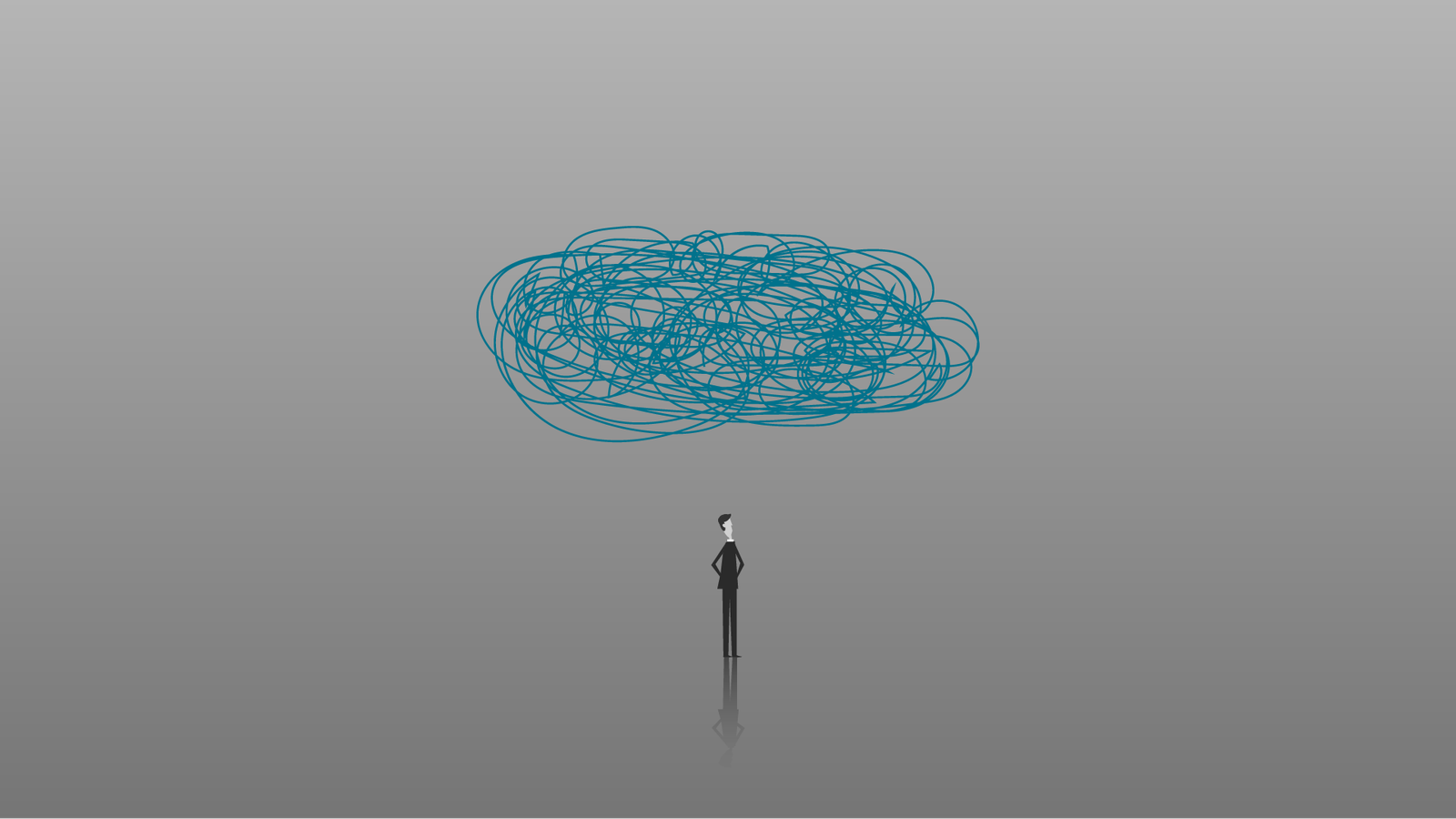Il mercato del lavoro è rotto
Un paio d’anni fa, prima della pandemia, lavoravo felicemente con un cliente che aveva un problema piuttosto comune: faticava a trovare persone con il giusto mix di competenze da assumere nella sua azienda.
E parliamoci chiaro, non stiamo parlando di ingegneri che avrebbero avuto la necessità di mandare dei razzi su Marte, ma di “semplici” commerciali junior, con competenze base nella creazione di presentazioni, e conoscenza almeno della lingua inglese, unita alla disponibilità a viaggiare molto, anche all’estero, per lavoro.
No, questo non è un articolo in cui ti racconto come ho magicamente risolto il problema usando solo una graffetta, del filo interdentale e una gomma da masticare. Qui è dove voglio ragionare sul fatto che viviamo in un contesto in cui il mercato del lavoro è fondamentalmente rotto. Lo era prima della pandemia, figuriamoci adesso, che le aziende non aspettano altro che marzo per licenziare le zavorre.
Nella tua azienda, potresti averci fatto caso, ci vogliono settimane, quando non mesi, per portare una nuova persona in azienda, mesi e settimane in cui la posizione resta scoperta.

Poi c’è tutto il mondo dei “recruiter brutti e cattivi che non ti mandano nemmeno il feedback“, e dei “candidati brutti e cattivi che rispondo agli annunci a muzzo“. Se sei su LinkedIn sai perfettamente di cosa sto parlando, non far finta di nulla.
Ci sono i Dr Jeckill durante i colloqui che si trasformano in Mr Hide non appena il loro nome va sul contratto di lavoro a tempo indeterminato. Durante i colloqui di selezione, ho notato, sono tutti bravi e perfetti. Perfino i difetti diventano un valore aggiunto. Per non parlare delle aziende, che sono sempre leader di settore, fino a quando non scopri che sono anni che se non chiudono in rosso è solo grazie a magheggi contabili.
La verità è che il gioco della selezione è a perdere.
Le aziende voglio persone, di solito le più brave possibili spendendo il meno possibile. E non parlo degli assurdi stagisti con esperienza, ma aziende serie e sane che non mettono il range di stipendio sugli annunci perché “se lo metto tanto il candidato vede solo la cifra più alta”.
I candidati per la maggior parte vogliono solo un lavoro. Meglio se li paga meglio rispetto al precedente e se il loro capo non è psicolabile come il capo precedente. Sì, lo so, ci sono anche quelli che inseguono un obiettivo professionale, che vogliono solo capire se la loro prossima azienda sarà un covo di matti come la precedente, oppure riusciranno a farci qualche passetto in avanti.
E non parliamo degli intermediari, degli head hunter, delle società di recruiting. Il loro cliente, non dimentichiamolo mai, è l’azienda. Non il candidato. La persona è il prodotto ad essere venduto.
Sì, lo so, non tutti sono così. Ci sono anche i bravi, ci sono gli etici, gli onesti.
Ma la verità è che è il processo ad essere pensato male. Forse non è il mercato del lavoro ad essere rotto, ma proprio le aziende.