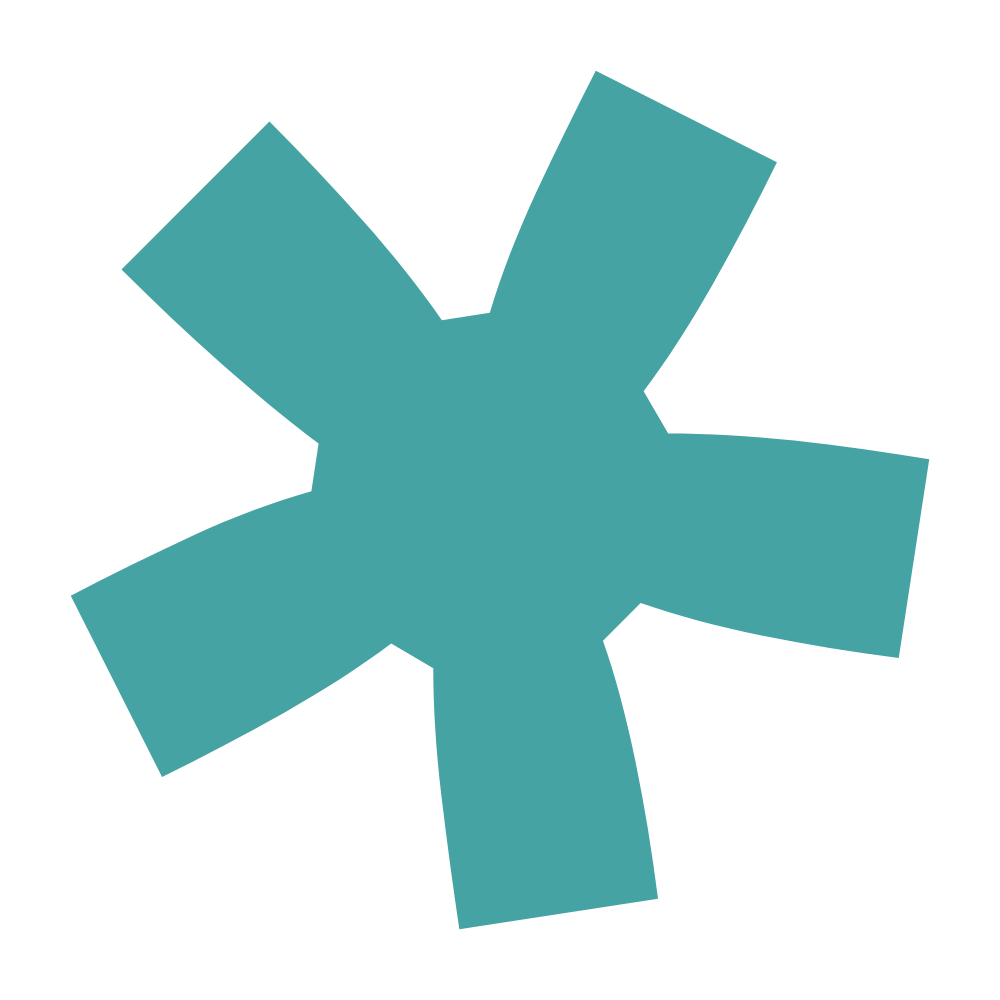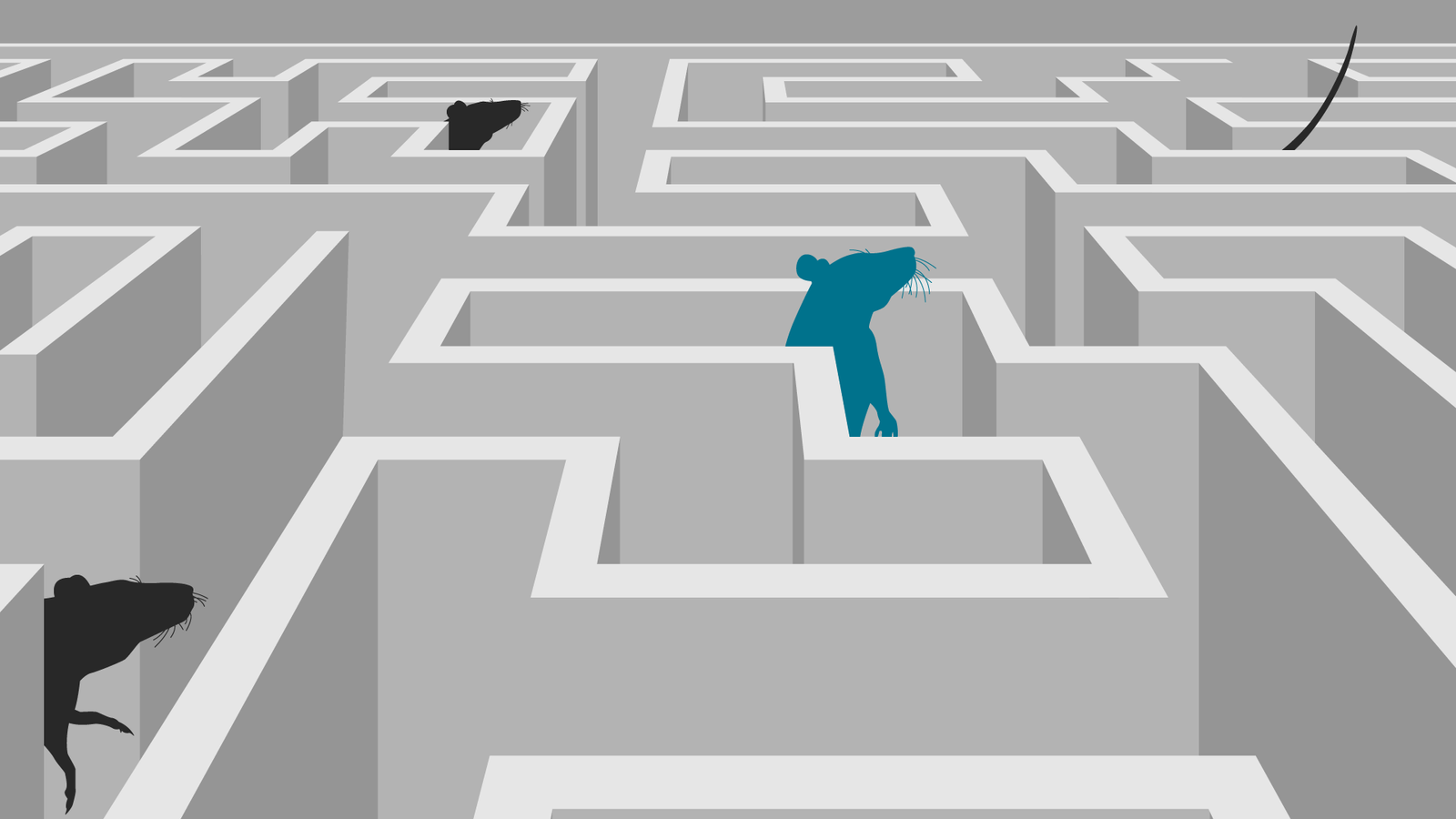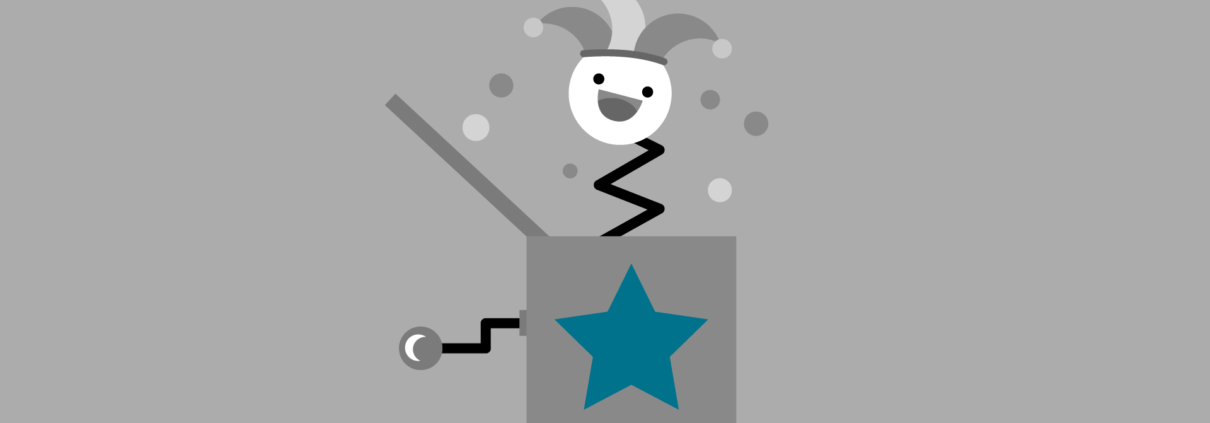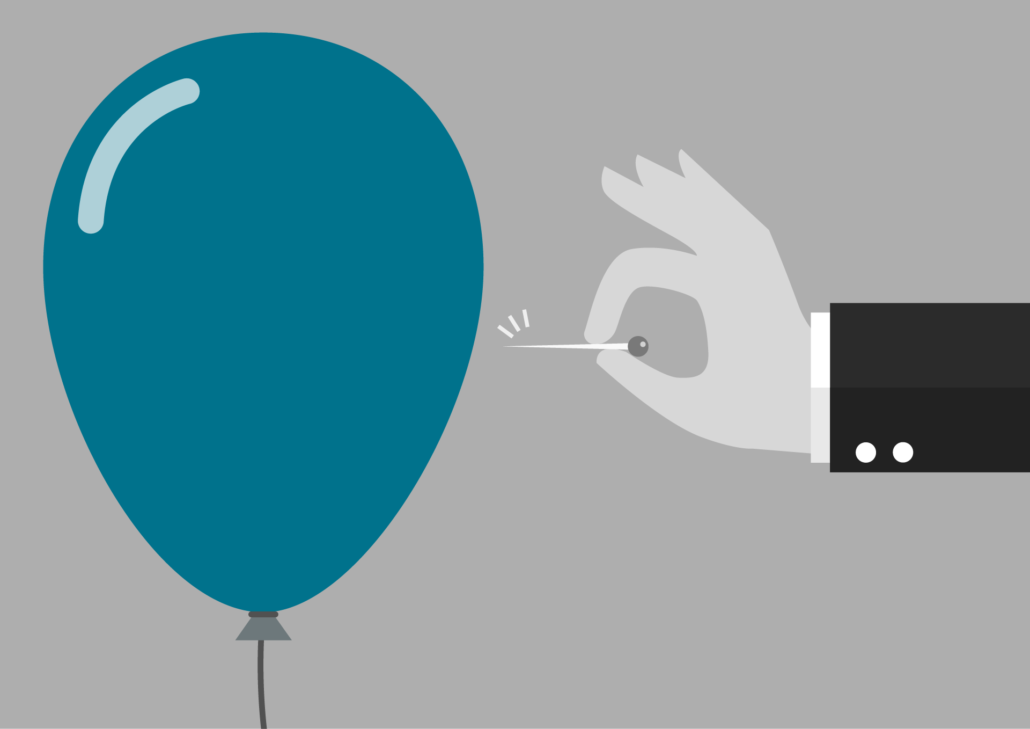Mercoledì è un buon giorno per Invecchiare
Partiamo dalle cose ovvie, e meno interessanti: oggi compio 32 anni, quindi, ufficialmente, invecchio.
Stavo scrivendo un altro articolo, per oggi, ma visto che il mio compleanno cade in coincidenza con il mio articolo settimanale ho cambiato idea. Più che altro, come spesso capita in queste occasioni, mi sono fermato un po’ a riflettere. D’accordo, probabilmente capita solo a me.
Non sono uno che vive con grande anticipazione i compleanni. La vedo più come una scusa per trovarsi tutti insieme, mangiare e bere bene, e passare un po’ di tempo in compagnia. Ricordo che quando andavo al liceo, invece, era un conto alla rovescia a quel momento in cui sarei arrivato a 18, e sarei diventato un essere umano fatto e finito, almeno per la legge. Quel momento è passato e scivolato via. Un giorno mi sono svegliato, e mi sono accorto che non era cambiato nulla per me.
Ho, però, un ricordo antecedente che oggi, per qualche motivo, mi è tornato alla mente. Frequentavo la scuola media, e per un paio di mesi mi alzavo tutte le mattine con il terrore di invecchiare. Che è una cosa buffa, se ci si pensa. Un bimbo, a dodici anni, non è nemmeno ancora un adulto, e in tutta sincerità non ho idea di cosa avesse acceso quella fobia, se non il fatto che, per via del divorzio dei miei genitori, era un periodo un po’ di schifo, ma in tutta sincerità non sono nemmeno sicuro che le due cose siano collegate tra loro.

Non era tanto l’idea della morte che mi spaventava, quanto il pensiero che mi sarei avvicinato ad essa come un vecchio malato, incapace di muovermi, magari con i primi segni di demenza. Sentivo l’ansia per la fatica che avrei fatto a svolgere gesti quotidiani, come alzarmi da seduto, o andare da un posto all’altro sulle mie gambe.
Così com’era arrivata, quella sensazione sparì, e devo dire che, per quanto di tanto in tanto mi torni alla mente, ha completamente perso il suo potere, e ad oggi resta per me solo un ricordo buffo. Eppure, nonostante non sia certo in là con gli anni, una vita di sport hanno lasciato su di me qualche cicatrice, come una spalla lussata, un ginocchio che alle volta gioca qualche brutto scherzo, e una schiena che mi ha costretto per la prima volta ad andare dall’osteopata. Lo sport che pratico oggi è il Taiji, e l’età media della palestra è superiore ai 50 probabilmente solo perché ci sono io ad abbassarla. Fisicamente mi sento un vecchio rinsecchito, e la cosa mi fa ridere.
Mi fa ridere perché so di non esserlo, e se anche lo fossi non sarebbe un problema. Da molto tempo, infatti, ho semplicemente imparato ad accogliere il mio presente con gentilezza. E tutto sommato trovo che il mercoledì sia un buon giorno per invecchiare per me, quest’anno. Un giorno di intermezzo che si limita a scivolare via come se nulla fosse. Eppure, stamattina mia moglie si è alzata prima di me, e ha preparato i Waffles. Quando sono arrivato in cucina, mi ha fatto trovare un piccolo regalo: un portachiavi per l’auto nuova, della Lego, quello con la figura di Dart Vader.
Io allora mi sono girato verso mia figlia, che era sul seggiolone, e con la figurina in mano le ho detto “Sono tuo padre!“
Non sono sicuro che abbia capito, però almeno si è messa a ridere.