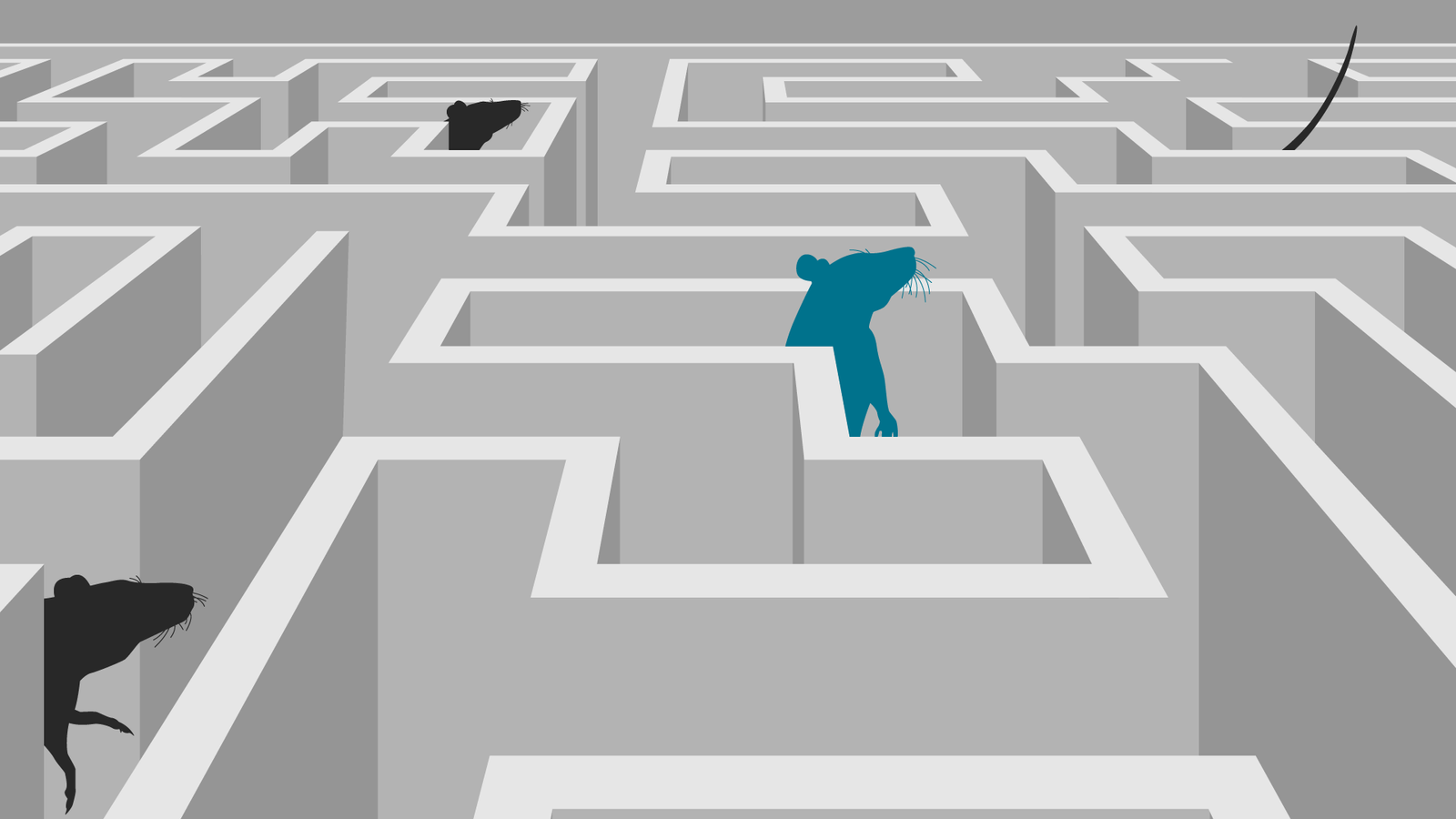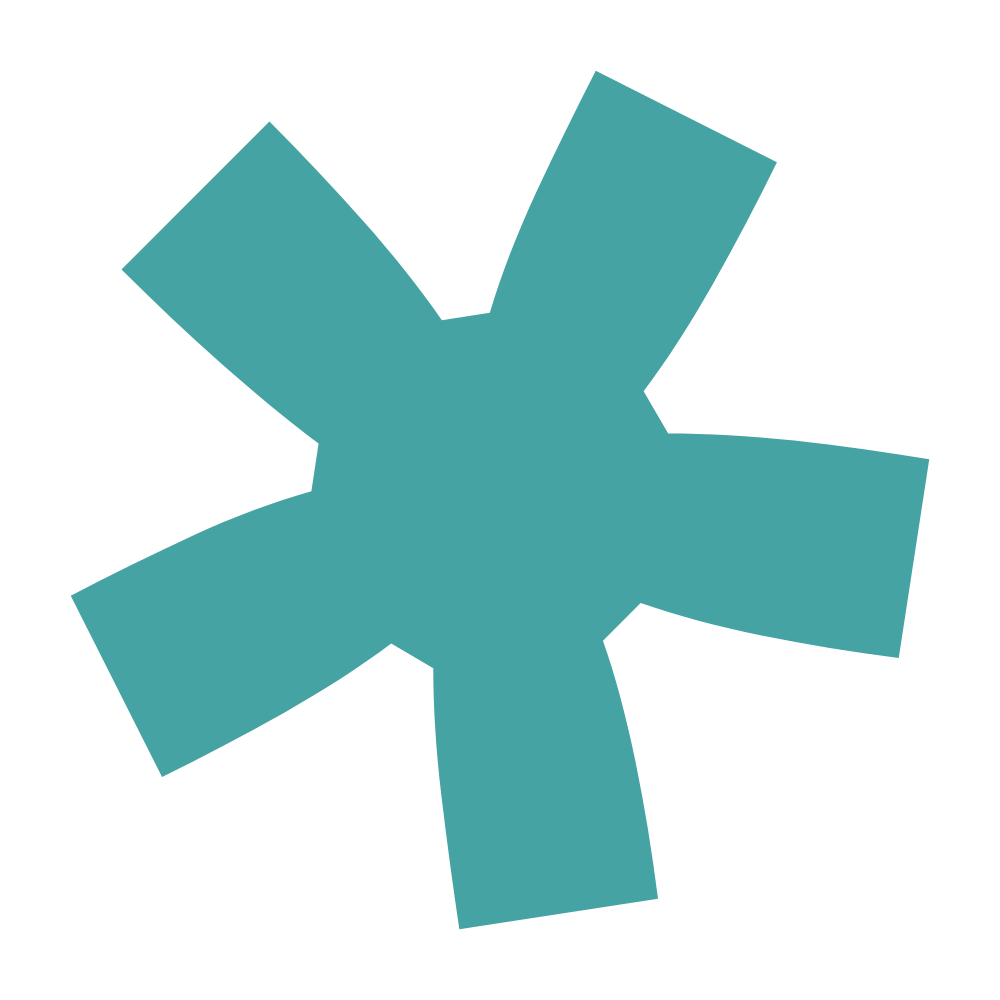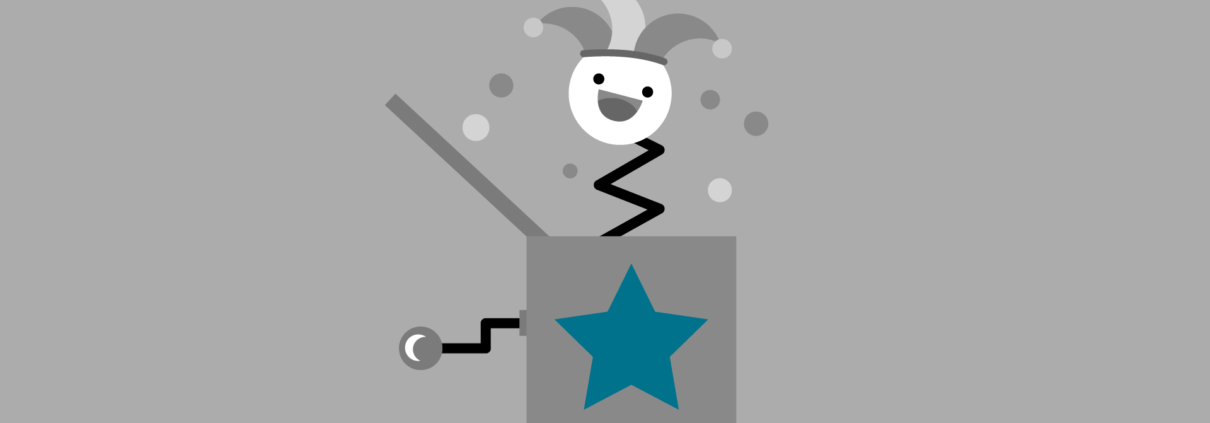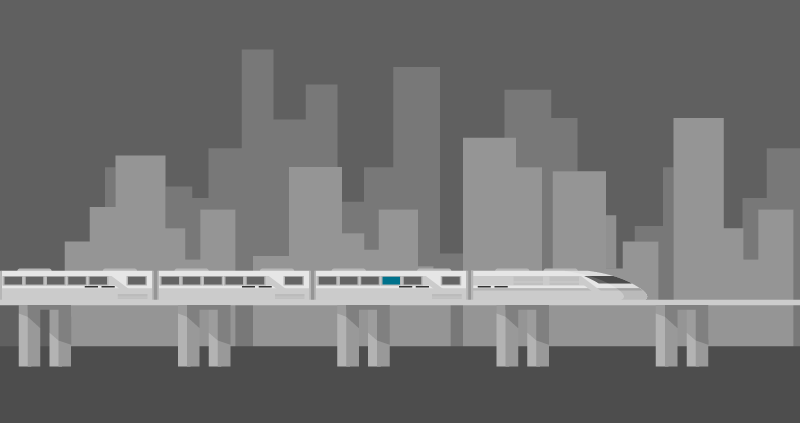Da ormai molti anni sono appassionato di manga giapponesi. Li preferisco notevolmente ai comics americani, forse perché in essi vedo un modo di pensare e una cultura più vicina ai valori che sento miei, ma non è questo il punto. Uno dei topos principali di tutti gli stili fumettistici è l’esistenza del superpotere. Insomma, vuoi perché ci si nasce, si mangia un frutto del diavolo, o si viene punti da un ragno radioattivo, il protagonista della storia si trova a possedere dei poteri fuori dal comune.
E se è vero che da un grande potere derivano grandi responsabilità, il protagonista in questione si imbarca per il suo viaggio dell’Eroe, sconfiggendo le proprie debolezze, oltre che i nemici sempre più forti che il narratore gli mette davanti, con l’obiettivo di salvare il mondo, diventare Hokage, o quello che è.
Mi sono sempre pigramente chiesto che cosa farei se avessi dei superpoteri, come quelli dei Manga. Mi piace pensare che li userei il mondo, ma molto probabilmente sarei più come Saiki Kusuo: farei tutto il possibile per passare una vita tranquilla, senza farmi stressare da nessuno. Poi, pensandoci meglio, mi sono reso conto che anche io ho dei superpoteri: ci sono delle cose che so fare soltanto io, e probabilmente poche altre persone al mondo. Eppure sono perfettamente inutili, un po’ come il potere di vedere solo attraverso le foglie d’acero, oppure di usare la telepatia con gli scarabei stercorari.
Ma mi sono reso conto che molti di questi superpoteri inutili li uso costantemente nel mio lavoro. Ecco quindi una raccolta semiseria di tratti inutili che mi contraddistinguono. Vedi mai che scopra che lì fuori ci sono persone strambe come me, o che magari anche tu, leggendo, hai altri tratti totalmente inutili, ma che tu in qualche modo riesci a valorizzare.
Il mio punto cieco è dove guardo
Da qualche anno, ormai, ho manifestato una condizione genetica nota come cheratocono corneale. In buona sostanza, le mie cornee con il passare del tempo, assumono una forma strana, e io perdo progressivamente la vista. Nel mio caso (ma è la normalità) essa si manifesta sul mio fuoco: significa che se guardo qualcosa, la mia capacità di vederla peggiore drasticamente.
Dopo alcuni anni, mi sono reso conto che questo mi rendeva molto più attento a notare dettagli ai margini del mio campo visivo. Insomma, se sto guardando qualcuno, riesco a notare l’espressione stranita o felice di chi mi sta di fianco. Insomma, il mio punto cieco non è dietro di me, è davanti!
Quando uso questo superpotere? Soprattutto quando lavoro come docente in aula: se sto spiegando qualcosa a qualcuno, riesco sempre a cogliere le reazioni del resto dell’aula.
Penso troppo veloce
Uno dei miei primi ricordi, quando ripenso a mia madre, è una sensazione della differenza di velocità tra lei e mio padre, o chiunque altro, nel parlare. Non so se sia mia madre che mi ha influenzato in questa direzione, o la mia sia una dote naturale, ma mi rendo conto che il mio cervello è costantemente su di giri. Ad esempio, non sono capace a leggere a voce alta, perché la mia velocità di lettura a voce è infinitamente più lenta di quella a mente.
Il che spesso è un problema, perché quando parlo accelero senza accorgermene. A un certo punto mi ritrovo che sto andando ad una velocità per me confortevole, e il mio interlocutore sta boccheggiando per venirmi dietro. Insomma, quando parlo con altre persone, la mia è una vita con il freno a mano tirato.
Quando uso questo superpotere? Questa capacità mi è particolarmente utile nel corso di consulenza e coaching. Se in questi contesti mi risulta più facile sintonizzarmi con la velocità del mio interlocutore, la mia velocità di pensiero mi aiuta a vedere tutta una serie di possibili scenari da percorrere, per aiutare il mio cliente al meglio.
So non pensare a qualcosa
Questo è divertente, e doloroso allo stesso tempo. Divertente perché teoricamente è impossibile: pensare di non pensare a qualcosa è di per sé pensare a quella cosa (e infatti ci riesco usando un trucchetto mentale). Doloroso perché ha a che fare con un periodo della mia vita particolarmente difficile, in cui sono stato travolto dalla negatività, per uscire dalla quale ho sviluppato questo talento.
L’idea è una sorta di tecnica di visualizzazione. Immagina di vivere da molti anni in una casa caratterizzata da un lungo corridoio, su cui danno le varie stanze della casa. Immagina che sul lato destro del corridoio ci siano nell’ordine un bagno, uno studio, e una camera. Ora, se ho bisogno di arrivare alla camera finale, non ho bisogno di entrare nelle due porte precedenti. Potrei al limite gettare un’occhiata distratta alla porta, ma se volessi evitare anche solo di notare la porta dello studio, potrei semplicemente guardare a sinistra non appena noto la porta del bagno.
La mia mente funziona più o meno così: un grande labirinto pieno di porte, su cui ho un certo controllo a livello spaziale. Significa che se voglio evitare un pensiero mi è sufficiente percorrere una strada diversa, oppure focalizzarmi su altro, per evitare un pensiero specifico. All’atto pratico, se volessi evitare di pensare, ad esempio, a un elefante rosa, costruirei l’immagine di un ippopotamo blu, e qualora mi rendessi conto di avvicinarmi alla combinazione animale+colore focalizzerei sull’ippopotamo blu, per poi deviare verso altri pensieri.
Quando uso questo superpotere? Questa strategia mi è stata particolarmente utile in passato per superare momenti difficili, ma ancora oggi la uso per evitare distrazioni specifiche, o focalizzarmi su qualcosa. Questa tecnica di visualizzazione ha anche a che fare con il mio stile di meditazione.
Vivo nel Presente
Un altro degli effetti collaterali del praticare meditazione da molti anni, e dell’essere morto una volta, è che vivo nel presente. Bella prova, direte voi, lo facciamo tutti. Eppure, per la maggior parte del tempo siamo proiettati verso il passato, o verso il futuro, e le nostre emozioni positive e negative le viviamo in funzioni di questo, non del presente.
Il che, in effetti, è un po’ strano, spesso. Capita soprattutto con mia moglie, che di tanto in tanto mi chiede che cosa mi aspetti da qualcosa, o se non sono preoccupato. E sembra prendersela sul personale quando le rispondo che di solito non mi aspetto nulla, né vivo emozioni negative rispetto ad un futuro ipotetico.
Quando uso questo superpotere? In effetti, lo faccio costantemente, ma mi è particolarmente utile quando mi trovo in situazioni dal carico emotivo molto forte, per poterle gestire in modo lucido.
Ho un’incredibile resistenza al dolore
Da quando ho ricordo ho sempre sofferto di mal di testa, delle forme emicraniche incredibilmente intense, e abbastanza regolari, tanto da essere catalogabili come dolore cronico. Da ormai molti anni convivo serenamente con questa condizione, che spingendomi su soglie di dolore fisico tali da portarmi allo svenimento, mi hanno di fatto reso pressoché immune ai dolori lievi.
Ad esempio, pur lussandomi spesso una spalla, riesco sempre a rimetterla in sede in autonomia, e senza particolari danni collaterali. Allo stesso modo, piccoli infortuni o interventi non mi creano particolare difficoltà. Che non significa che non senta il dolore, ma lo tollero incredibilmente bene.
Quando uso questo superpotere? Lo uso tutte le volte che provo del dolore fisico, in effetti, ma mi aiuta a vivere con ansia anche le piccole esperienze che contengono dolore, come le banali donazioni di sangue. Ho anche aiutato mia moglie a superare la sua ansia da parto, con una frase che per tempistica ed effetti è stata molto efficace con lei: “alla fine è solo dolore!“