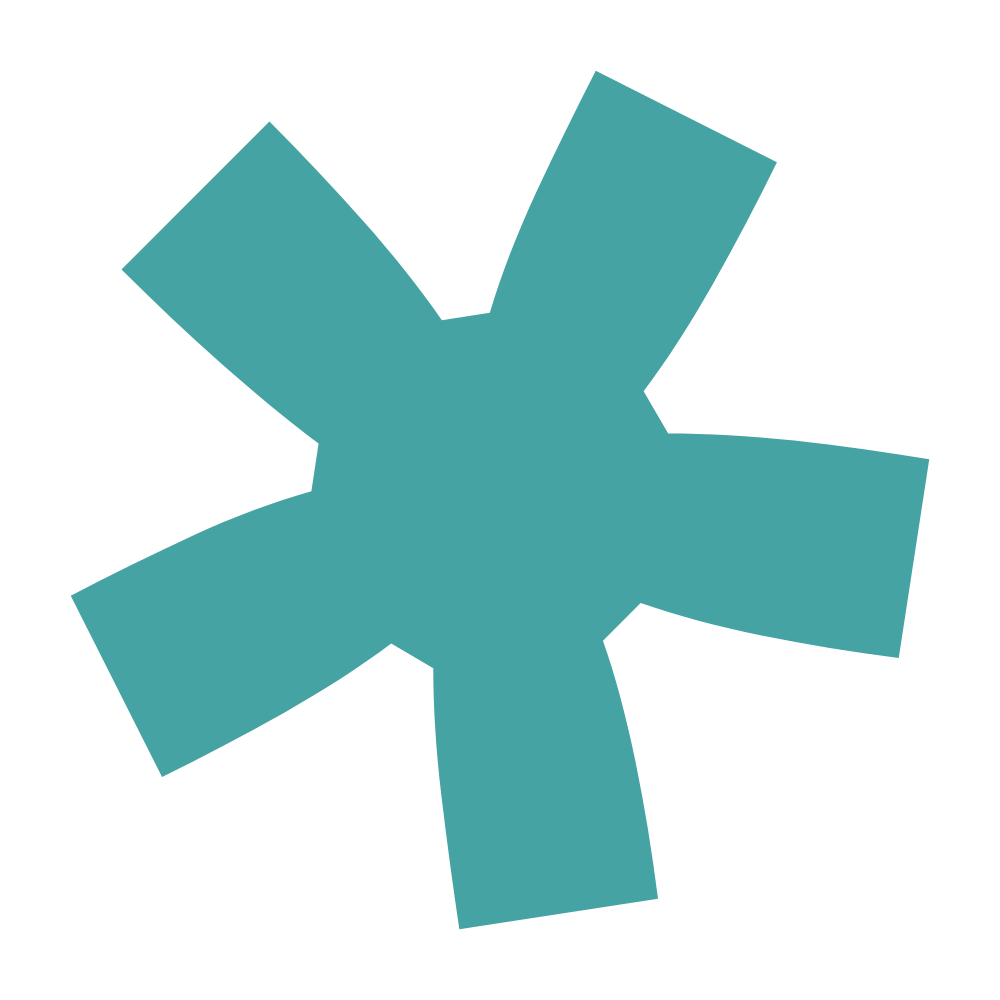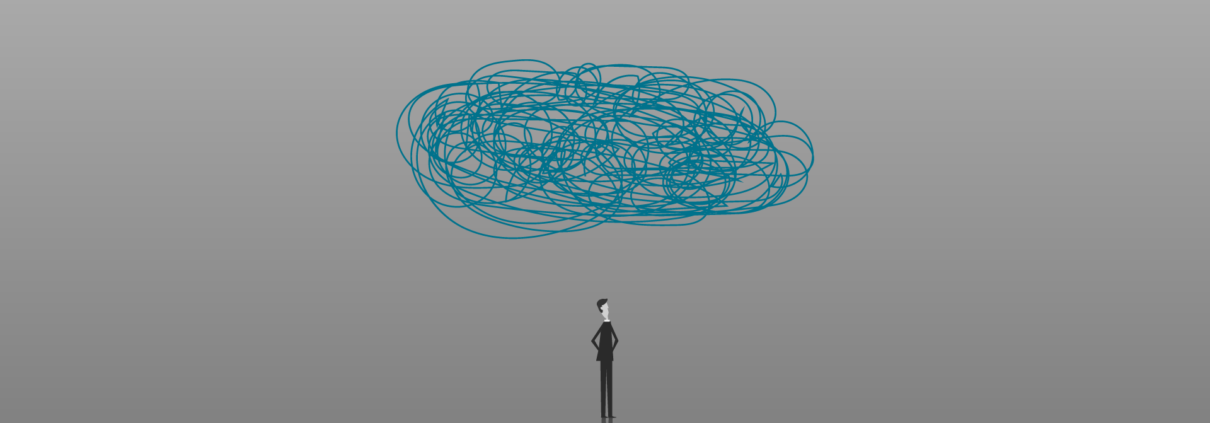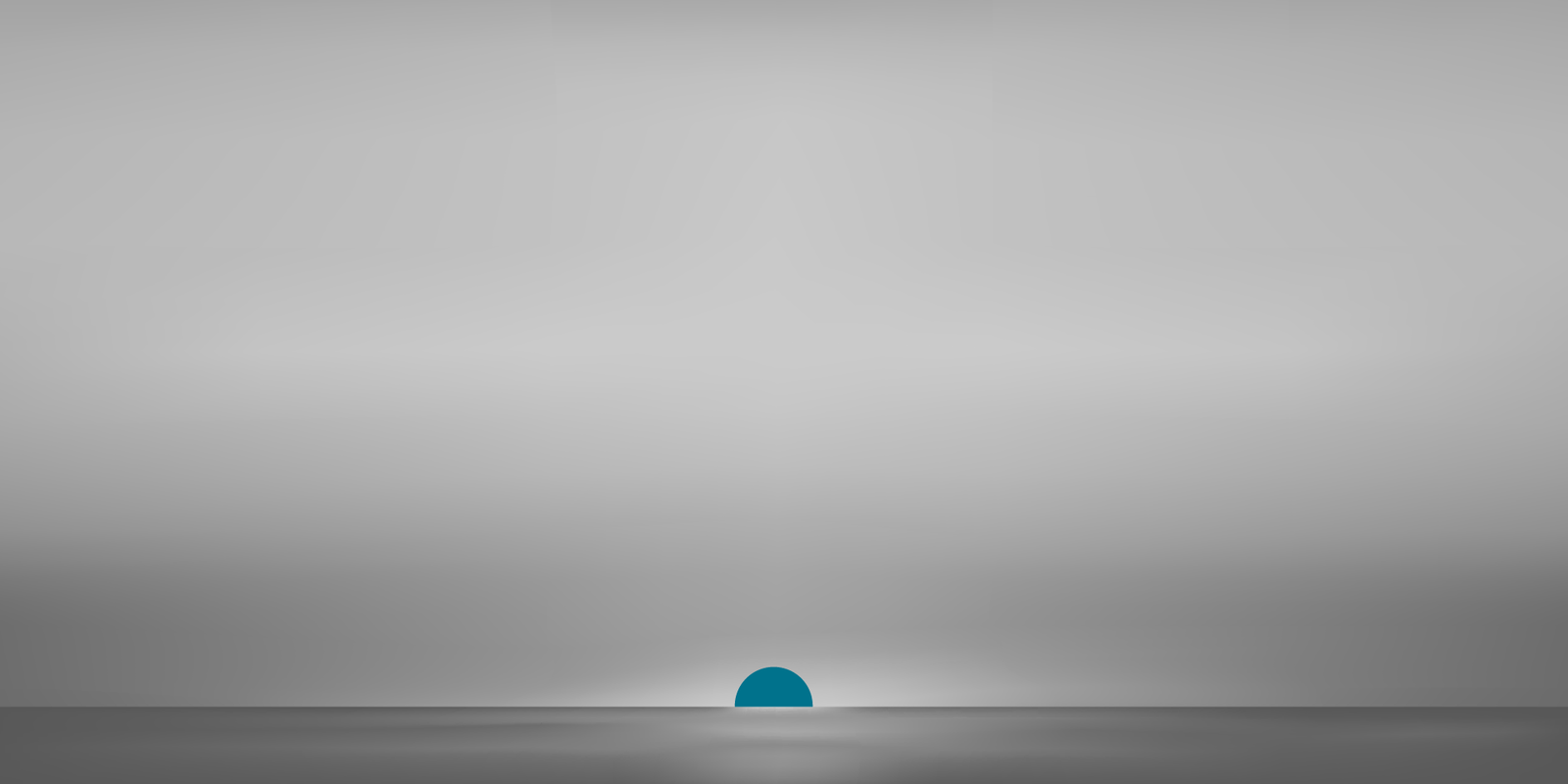Il Sogno del Manager
Lo conosco il sogno del manager.
Il mito del team perfetto, in cui tutti i collaboratori seguono con passione e dedizione la guida del loro leader. Il team in cui le persone sono autonome, e responsabili. Ma anche proattive e motivate. In cui le persone si fidano, tra di loro, e del loro capo.
Non ho mai conosciuto, ad oggi, un manager che rientrasse al 100% in questo sogno. Spesso basta un singolo collaboratore per spezzare l’incantesimo. Molto più spesso vedo l’incubo del manager, quello in cui le persone sono stanche e demotivate, fanno il minimo indispensabile, quando non si oppongono direttamente all’autorità del loro capo. Hanno bisogno di controllo e cazziatoni costanti anche per fare i lavori più semplici.
La soluzione facile, in questi casi, è pensare che la colpa sia dei collaboratori. Dell’organizzazione. Della politica. Della pandemia. Delle congiunzioni astrali. Ovviamente questa è una soluzione solo se l’obiettivo è mettersi la coscienza a posto, ma non risolve in alcun modo il problema.
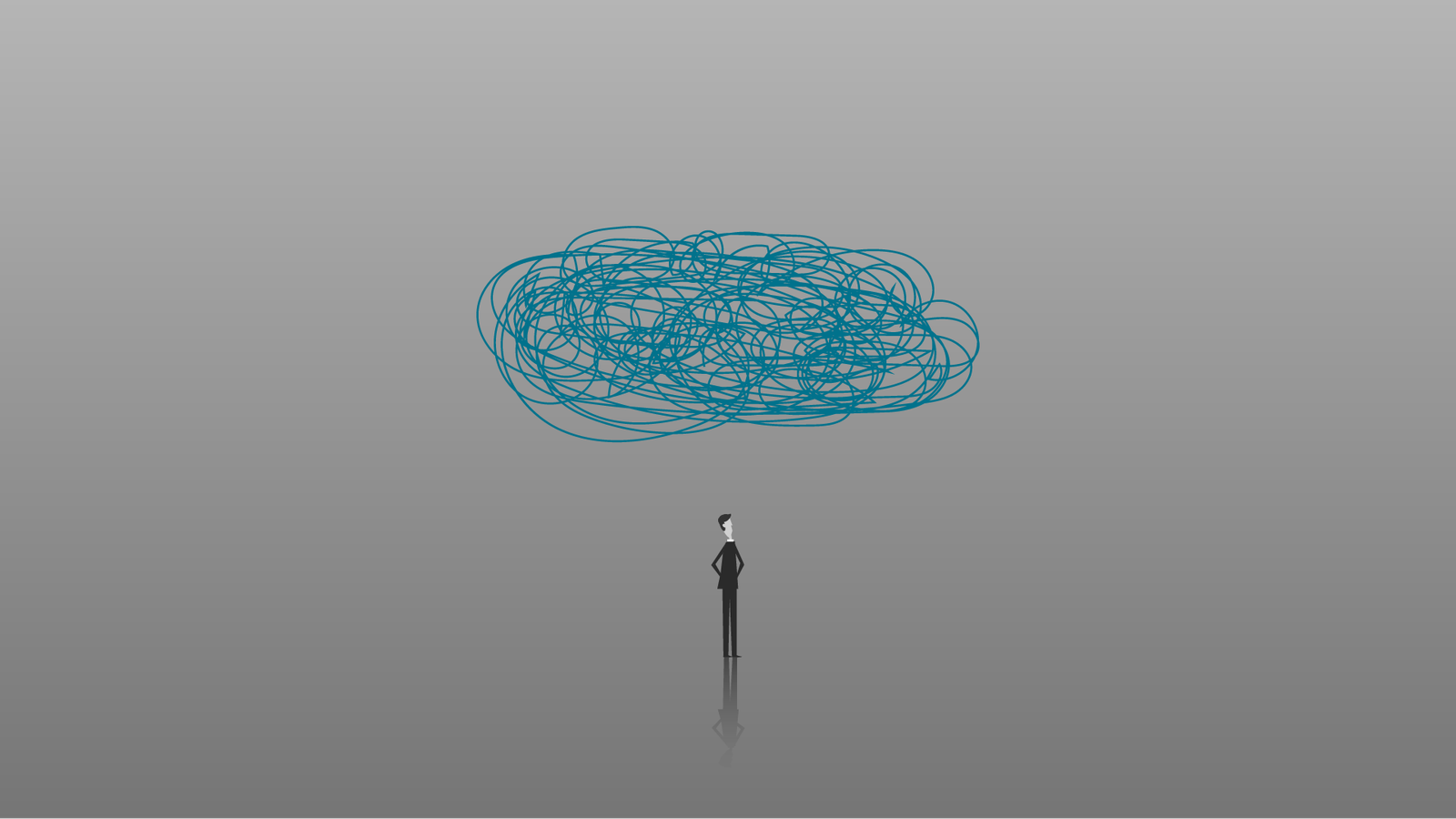
La verità è che come manager hai la responsabilità della scarsa performance dei tuoi collaboratori a prescindere. Perché se un collaboratore non funziona in un ruolo, ci possono essere, sostanzialmente, due classi di motivi possibili.
Il primo è che quella persona è, semplicemente, la persona sbagliata per quella posizione. E non c’è niente di male, voglio dire. Se a causa di qualche bizzarra congiunzione astrale domani dovessi essere assunto per riparare lavatrici, in quel ruolo non potrei mai funzionare, e produrrei solo della grande insoddisfazione nei miei clienti.
Il secondo è che quella persona non viene messa nelle condizioni di dare il massimo.
Ecco, sarebbe facile pensare che solo nel secondo caso il manager potrebbe fare qualcosa, e comunque dovrebbe prima capire di quale delle due casistiche si tratta. In realtà, il problema è molto più semplice: basta creare uno spazio in cui i collaboratori possano dare il massimo, in modo da riconoscere i secondi e stanare i primi. E di nuovo, la responsabiità sta, a questo punto, nel trovare il modo di allontanarli.
Ed ecco, così, miracolosamente avverato il sogno del manager. L’unico problema è che per raggiungerlo ci si deve, effettivamente, impegnare.